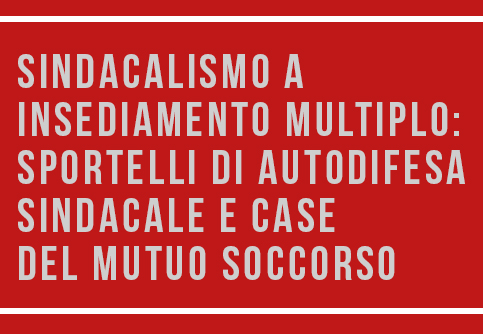Negli slum di Rosarno, ai confini dello sfruttamento
Viaggio nella Piana di Gioia Tauro, dove pochi giorni fa ha perso la vita Suruwa Jaithe, gambiano di 18 anni. L'ultima vittima tra migliaia di lavoratori che turbano i benpensanti ma ingrassano la grande distribuzione alimentare
Maurizio Franco e Maria Panariello
Rosarno è una «città video-sorvegliata». La dicitura è riportata su un cartello stradale alle porte del piccolo comune della Piana di Gioia Tauro, nello zoccolo calabrese dell’Italia meridionale. Oltre alle telecamere, gli sguardi dei rosarnesi si perdono nelle vie di un paese immobile. La città è una lingua di cemento percorsa ai lati da palazzine incompiute con i mattoni ancora in evidenza. Quasi a circondare il nucleo urbano di case scrostate e vie, si stagliano in lontananza terreni agricoli dove si coltivano kiwi, arance e mandarini. Una volta raccolti, i tesori della Calabria sono poi esportati sulle tavole di tutto il mondo.
A lavorare nei campi ci sono migliaia di migranti africani. Vanno in bicicletta. È l’unico mezzo che hanno per muoversi autonomamente. Sono maliani, nigeriani, senegalesi e gambiani. Alle prime luci dell’alba si ritrovano a gruppi vicino agli incroci, seduti sul ciglio delle strade e lungo la statale ad aspettare il caporale di turno. Forza lavoro da smistare nelle distese della Piana. Sfruttamento e alienazione nella filiera agrumicola.
Seguendo le pedalate quotidiane delle biciclette che escono dal centro di Rosarno, attraversando un sottopassaggio mentre le case si diradano, si sconfina nella zona industriale della città di San Ferdinando. Capannoni dismessi, hangar fatiscenti in un distretto produttivo fallito. Sulla linea dell’orizzonte, a pochi chilometri, si muovono le gru metalliche del porto di Gioia Tauro, uno dei più importanti porti del Mediterraneo. Questa zona è stata proclamata ad aprile “Zona economica speciale” (Zes). Nei prossimi anni sono previsti progetti di bonifica e sviluppo. Non è difficile immaginare chi ne farà le spese.
Ancora un paio di pedalate e infine si giunge alla baraccopoli: un imbuto di tende e lamiere, travi di legno attaccate a pezzi di cartone con nastro isolante. Una città scavata nel fango e nella plastica.
Ismahil ha ventisei anni ed è originario del Mali. In uno spiazzo di terra, tra le casupole improvvisate del ghetto, vende di tutto: vestiti, lenzuola, carica batteria e padelle. «Il mio sogno è raggiungere Londra, dove vive mio fratello – racconta alternando parole in italiano e in inglese – Ho studiato informatica nel mio paese e poi sono andato via». Abbassa lo sguardo, sorride imbarazzato. Dopo un lungo viaggio, tra le carceri libiche e la traversata del Mediterraneo, è giunto in Italia. È andato a vivere a Torino e ha conosciuto il lavoro agricolo nelle campagne di Saluzzo, comune a un’ora di treno dal capoluogo piemontese. Qui ha ottenuto la residenza, ma conclusa la stagione è stato costretto a spostarsi. «Un mio amico ha detto che a Rosarno c’era lavoro e sono partito» guardandosi intorno tra le tele incerate di plastica e i tetti delle baracche ricoperte di polvere. «Ho lavorato nei campi ma non ce la facevo più».
Morti di stato
Con l’approvazione del decreto Sicurezza, queste campagne e i ghetti che le circondano rischiano di diventare il rifugio di migliaia di migranti espulsi dal regolare sistema di accoglienza. Secondo le stime di Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi, entro il 2020 ci saranno oltre 60.000 irregolari in tutta Italia, che andranno ad aggiungersi ai 70.000 già presenti. Come effetto del provvedimento, decine di migranti sono stati cacciati dai Cas, dai Cara e dagli Sprar e in Calabria, sono andati ad aggiungersi ai migranti delle rotonde, che aspettano di lavorare. Proprio da uno Sprar arrivava Suruwa Jaiteh, il diciottenne gambiano morto sabato 1 dicembre, in un incendio divampato nel ghetto di San Ferdinando. Secondo alcune testimonianze, Suruwa si era recato nelle baracche per fare visita ad amici, ma il calore di un braciere acceso per scaldare il capanno in plastica gli è costato la vita. Il ragazzo viveva a Gioiosa Ionica, dove da febbraio era ospite di uno Sprar gestito dalla rete dei comuni Solidali e a dicembre avrebbe dovuto cominciare un tirocinio di 4 mesi. Secondo altre voci, sarebbero state le conseguenze del decreto Sicurezza a spaventare il giovane, che aveva quindi deciso di fuggire in campagna. Pochi mesi prima, a gennaio, un altro incendio nel ghetto di San Ferdinando, questa volta di natura dolosa, ha provocato la morte di una ragazza nigeriana di 26 anni, Becky Moses. Costretta a lasciare lo Sprar di Riace dopo il rifiuto alla seconda richiesta di asilo, Becky si era rifugiata in queste baracche. Morti di dinieghi, di fughe, di paure, di indifferenza.
Il 2 giugno, a San Calogero – 20 chilometri circa dalla baraccopoli – è stato ucciso Soumayla Sacko, bracciante maliano di 29 anni, attivista dell’Usb. Soumayla è stato raggiunto alla testa da un colpo di fucile, mentre aiutava altri due connazionali a recuperare dei pezzi di lamiera per rinforzare le baracche di San Ferdinando. I tre si trovavano all’ex fornace “Tranquilla”. Una fabbrica di mattoni messa sotto sequestro per le oltre 135mila tonnellate di rifiuti tossici ritrovate dalla guardia di Finanza. Una discarica abusiva controllata da apparati criminali. La presa della ‘ndrangheta su queste terre è forte, è palpabile e si insinua soprattutto nelle maglie del sistema produttivo e agricolo.
Un arcipelago di baracche
A otto anni dalla rivolta dei braccianti, a Rosarno e nei comuni limitrofi, si continuano ad adibire alloggi temporanei, che diventano fatiscenti appena si esauriscono i fondi. È successo nel 2012 con la prima tendopoli, diventata subito invivibile per l’assenza di un gestore, quindi sgomberata nel 2013. Mentre le baracche che vediamo oggi, quelle in cui hanno perso la vita Suruwa e Becky, altro non sono che i resti del secondo insediamento, ricreato nello stesso luogo del primo. Un agglomerato di plastica e terra, che nel pieno della stagione agrumicola, arriva ad ospitare 2 mila persone. Accanto a questo slum, fino a maggio, sorgeva il capannone Rizzo, un edificio industriale caduto anch’esso in stato di abbandono, dopo la “fuga” dei gestori, ora sgomberato. Poco lontano, sulla stessa strada, si estende la nuova tendopoli del ministero dell’interno, inaugurata nell’agosto 2017, in grado di accogliere circa 500 persone. Un quadrato di tende blu e bianche, recintato da una rete su cui svettano telecamere di video sorveglianza. Le persone che alloggiano in questo campo devono essere in possesso di permesso di soggiorno e presentare un badge in entrata e uscita. Prime sperimentazioni di politiche securitarie all’alba del governo giallo verde e del decreto Sicurezza.
La nuova struttura è stata acclamata dalle istituzioni locali come una soluzione al degrado della baraccopoli confinante. Tuttavia l’opera – che è costata circa 700.000 euro (405.000 euro del Viminale e 300.000 euro della Regione) – non rappresenta una soluzione a lungo termine ed è destinata a essere sgomberata o trasferita, visti i progetti di sviluppo previsti nella Zes. Per superare il livello emergenziale del discorso alloggiativo, che isola i braccianti rendendoli invisibili al centro abitato, in questa zona servirebbero progetti di accoglienza diffusa. In una regione spopolata come la Calabria, sono molti i comuni che hanno aperto le loro case sfitte e hanno trasmesso ai migranti mestieri e saperi locali. È ormai noto il caso di Riace, in provincia di Reggio Calabria, dove circa 500 migranti vivono in appartamenti in affitto e lavorano in sinergia con i residenti. Un progetto mutualistico riconosciuto in tutto il mondo, cancellato dal Viminale con un decreto e con l’arresto e l’esilio del sindaco Domenico Lucano. Anche a Drosi, comune di Rizziconi, 8 anni fa è iniziata un’esperienza simile con il sostegno della Caritas locale, che si è resa garante del pagamento degli affitti. Oggi 150 migranti vivono in 20 case circa.
Per chi cerca un riparo, la campagna circostante offre centinaia di casolari abbandonati. Come il Casale 2 – nome che ricorda una precedente occupazione, sgomberata anni prima – nel comune di Taurianova, dove tra ulivi e agrumeti, si fanno spazio rottami di auto e baracche pericolanti. Nella cascina diroccata e nelle baracche costruite attorno allo scheletro di mattoni, vivono 150 persone. Soffrono di dolori articolari, contrazioni allo stomaco e difficoltà respiratorie. Dormono su materassi ammassati nei cunicoli di plastica.
«Non posso permettermi una casa vera e questo è l’unico posto» racconta Diallo, un bracciante senegalese di 23 anni. «Qui è come se non esistessimo». Nella piazzola di terra e rifiuti, i suoi compagni accendono un fuoco. Con delle taniche – incastrate tra la sella e il sellino della bicicletta – qualcuno va a prendere acqua potabile, pedalando fino ad una pompa di benzina sulla strada provinciale. «Non abbiamo niente, nemmeno l’elettricità», dice. Altri braccianti tornano dai campi e altri se ne vanno alla ricerca di cibo.
Le radici dello sfruttamento
La maggioranza dei lavoratori migranti che arrivano nella Piana di Gioia Tauro sono stagionali: vanno di regione in regione, in base al periodo della raccolta. In Puglia e in Basilicata per i pomodori in estate, in Piemonte e Toscana per l’uva in autunno. Negli ultimi mesi però, anche per l’aumento dei dinieghi alle richieste di asilo, sono cresciuti gli stanziali, ossia coloro che restano nella Piana tutto l’anno e con l’approvazione del Decreto sicurezza, la situazione andrà peggiorando. Gli stanziali più fortunati lavorano come magazzinieri, nella potatura o nell’allevamento.
I braccianti lavorano fino a 10 ore al giorno per tutta la settimana. Secondo il rapporto I dannati della Terra di Medici per i diritti umani (Medu) l’80 per cento dei lavoratori non ha un contratto regolare. Contrariamente alla propaganda del Governo pentaleghista, «la maggior parte dei braccianti è in possesso di un permesso per motivi umanitari (45 per cento) o per richiesta di asilo (41,4 per cento)».
«Nel rosarnese l’attenzione è tutta sui migranti, ma il problema sono i diritti degli stagionali. Questa prospettiva alimenta una logica securitaria ed emergenziale. Gli ostacoli principali sono i mancati controlli, una normativa lenta e lo strapotere dei colossi distributivi» dichiara Nino Quaranta, uno dei portavoce di Sos Rosarno. Un progetto nato dopo la rivolta del 2010, grazie ad un gruppo di agricoltori calabresi – vessati dai prezzi troppo bassi stabiliti dai commercianti all’ingrosso – e da alcuni braccianti scappati dal giogo del caporalato. Arance e olio prodotti in maniera sostenibile negli appezzamenti di terra della Piana e venduti direttamente ai consumatori in tutta Italia attraverso la rete Fuori Mercato. Prezzi equi e rispetto delle condizioni di lavoro. Ma anche organizzazione e conflitto.
Non si può parlare di sfruttamento senza parlare di filiera ortofrutticola, che parte dai campi e finisce sugli scaffali dei supermercati. E quindi, dei suoi vertici. «Controllando quasi il 75 per cento di tutto il cibo e le bevande consumate in Italia, i supermercati hanno l’enorme potere di riversare sulla filiera di produzione le dinamiche di prezzo con cui si sfidano quotidianamente a suon di volantini delle offerte. Il consumatore risparmia, la Gdo scongiura il crollo delle vendite e mette al sicuro i ricavi, ma qualcun altro nei vari passaggi di un prodotto dal campo alla tavola paga il prezzo di un gioco di potere iniquo in cui a perderci è chi ha meno potere contrattuale» è quanto scrive Oxfam in Al prezzo giusto, il suo ultimo rapporto. L’organizzazione internazionale delinea le responsabilità della Grande Distribuzione, interrogando i 5 principali player italiani sulle storture della filiera, lanciando una campagna a difesa dei lavoratori e dei piccoli agricoltori.
Vessazioni, sconti imposti ai produttori, pratiche commerciali inique, come le aste al doppio ribasso indagate da Fabio Ciconte e Stefano Liberti in un’inchiesta pubblicata su Internazionale: è il buyer power delle catene distributive che decidono il buono e il cattivo tempo di un intero settore. I prodotti venduti “sottocosto” ne sono la dimostrazione lampante. «Quest’anno le arance calabresi sono state vendute a 8-10 centesimi al chilo. Il piccolo produttore non ce la fa neanche a raccoglierle, quindi o abbandona i frutti sugli alberi oppure sfrutta chi è più debole, ossia i lavoratori – dichiara Quaranta. E in questa fase nessuno sembra capire che, se i prezzi sono così bassi, la colpa non è dei migranti».
*Maurizio Franco e Maria Panariello sono giornalisti freelance. Hanno scritto reportage per L’Espresso, Mediapart, Open Migration. il Fatto Quotidiano e Left. Hanno vinto la quinta edizione del Premio giornalistico televisivo Roberto Morrione con l’inchiesta Le catene della distribuzione, andata in onda su Rainews. Inoltre hanno curato il focus Il (povero) diavolo nascosto nel dettaglio nel Rapporto Magna Roma per l’associazione Terra! Onlus.
Dal sito https://jacobinitalia.it